OLTRE LA SOGLIA...
IL MISTERO
Carlo José Seno
La
soglia
Nel mistero del dolore: l'angoscia
Nel mistero del dolore: l'abbandono
Pasqua è gioia
Pasqua è vita
Pasqua è danza
Conclusione
RISONANZE SU UN ASCOLTATORE
Nella veste di prete e di pianista, ma - più
che altro - nella veste di un uomo che cerca un senso, un volto,
voglio proporvi un cammino, per percorrere insieme
quest'avventura: andare «Oltre la soglia ... » per
incontrare «il Mistero».
La soglia
Perché «la soglia»?
Perché ritengo importante soffermarci e indugiare, per un
attimo, sulla soglia del Mistero, prima di entrare e partire per
questo itinerario.
Abbiamo bisogno di renderci conto di ciò che stiamo per
fare.
Cos'è «la soglia»?
Un poeta, Rainer Maria Rilke, la definisce così:
«Soglia: oh, pensa che è, per due
che si amano
logorare un po' la propria soglia di casa già alquanto
consunta,
anche loro, dopo dei tanti di prima,
e prima di quelli di dopo... leggermente» 1.
Perciò, logoriamo leggermente la soglia anche noi,
ora aiutati da un grande artista: Claude Debussy.
Come tutti gli autori impressionisti, Debussy non delinea bene i
contorni di quello che vuole raccontare, ma offre delle
suggestioni, delle intuizioni.
Lui stesso, nelle raccolte dei Preludi per pianoforte, non
dà titoli ai suoi brani; ma, in conclusione, tra parentesi
e dopo tre puntini di sospensione, offre un'immagine. Come a
dire: «Questo brano è nato da questa ispirazione, ma
sentitevi pure liberi di considerarlo a partire dalla vostra
sensibilità».
Nel Preludio n. 4 del Primo Libro annota questo verso suggestivo
di C. Baudelaire:
( … «I suoni ed i profumi
volteggiano nell'aria della sera»)
Ci sono poi due aggettivi che Debussy pone all'inizio di
questo brano: armonioso e flessibile, che invitano ad un
ritmo sciolto e non rigoroso.
Alcuni flash:
All'inizio la carezza di un
profumo, inatteso e attraente
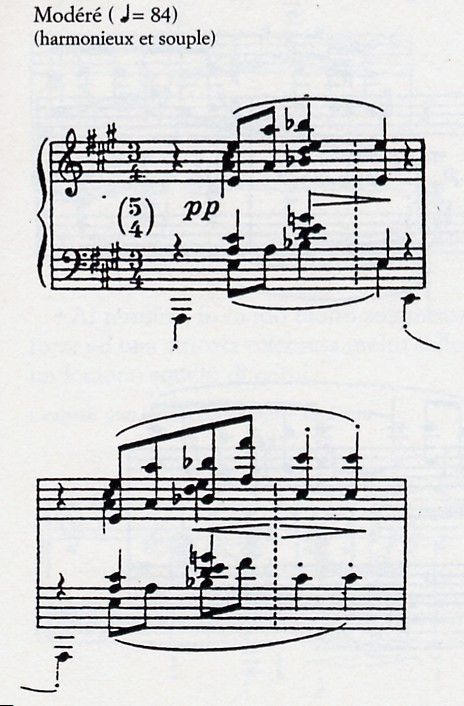
Entrando, e in seguito, nel «mistero» c'è
come un momento sofferto, un piccolo dolore lancinante che ben
presto scompare

Poi, tutto sembra «galleggiare nell'aria»
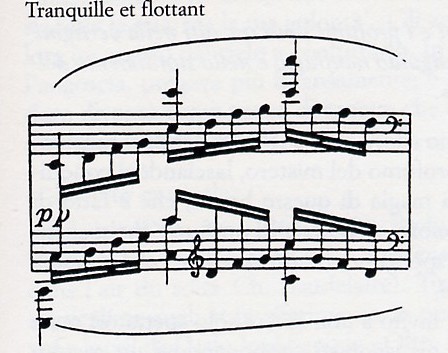
Al termine, in modo molto sommesso, allude forse ad una vittoria
celebrata molto sullo sfondo: un lontano squillo di corni.
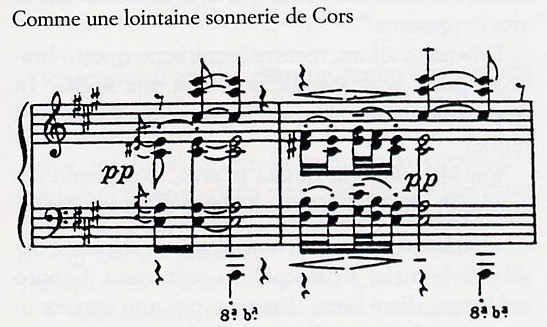 1
1
Un commentatore di questo brano, Vladimir
Jankélévitch, dice:
«I suoni e i profumi sono travolti nella
vertigine di un languido naufragio e nello stordimento
dell'estasi».
Restiamo allora sulla soglia lasciandoci raggiungere dal
profumo del mistero, lasciandoci conquistare dalla magia di
questo brano, che è fatto di chiazze sonore, di ventate di
profumo che si spandono e si spengono, di armonie che continuano
a rincorrersi.
Però vi invito a non essere solo spettatori ma a diventare
protagonisti proponendovi un ascolto attivo. Occorre quindi che
ci chiediamo: cos'è per noi la soglia?
Sappiamo che la soglia, per tanti, è il dolore, la fatica,
l'indifferenza della gente, le difficoltà che la vita ci
presenta.
Proviamo allora, mentre ascoltiamo questo brano, a porci la
domanda: qual è la mia soglia? In questo momento, su quale
soglia la mia vita si protende?
Per introdurci in questa ricerca, ricordiamo l'esperienza che
Gesù stesso ha fatto di questa soglia:
«Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli
Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse
loro: "Pregate, per non entrare in tentazione". Poi si
allontanò da loro quasi un tiro di sasso e,
inginocchiatosi, pregava: "Padre, se vuoi, allontana da me questo
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà".
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda
all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra»
(Luca 22, 39-44).
Ascolto musicale:
Claude Debussy (1862-1918), Preludio n. 4,
Primo Libro ( ... «Les sons et les parfums tournent dans
l'air du soir» Ch. Baudelaire). Tutti i brani musicali ai
quali si fa riferimento in questo testo sono incisi da Carlo
José Seno in «Oltre la soglia… il
mistero» (Distribuzione Città Nuova Nord -CD e
musicassette).
Nel mistero del dolore: l'angoscia
Ciascuno di noi ha dato un nome alla propria soglia.
Per Gesù la «soglia» era quella della Passione
e della Croce.
Per me ha avuto molti nomi: non capire per tanti anni il senso
della vita; non capire più dove dovevo andare; il buio; il
fallimento - qualche volta - in campo pianistico; la fatica di
capire - diventato prete - cosa dovevo fare; la sofferenza.
E sicuramente per ciascuno di noi questa «soglia» ha
oggi molte espressioni diverse.
Varchiamo ora la «soglia» ed entriamo nel
«Mistero», tenendo presenti le parole ben precise del
cardinale Martini nella sua lettera pastorale Ripartiamo da
Dio.
«Occorre misurarsi con l'Oltre, su quel
Mistero assoluto che ci intimorisce e ci attrae, di cui dolore e
morte sono come sentinelle» 2.
Ci può venire in aiuto un musicista di
straordinaria sensibilità, che ha vissuto profondamente
l'essere in questo modo «oltre la soglia» e dentro il
mistero del dolore: Fryderyk Chopin.
Chopin cerca di dirci questa esperienza con il suo modo autentico
e ricco di sottintesi (lui stesso diceva che non c'è nulla
di più odioso di una musica priva di sottintesi).
Cerchiamo di comprendere ciò che vuole dire questo
personaggio dall'animo trasparente, che sapeva raccontarsi con
grande intensità ed anche con un certo pudore.
Nella sua Seconda Sonata - conosciuta come Sonata della
«Marcia funebre» a causa del terzo movimento - la
nota dominante è il tema del dolore e della morte, ma con
una caratteristica particolare: sono sempre abitati dalla
speranza.
Alcuni flash:
Tutta la sonata è il
racconto di un dramma, che già all'inizio si apre con
tutte le sue caratteristiche sofferte. E' come un abisso che si
spalanca davanti al nostro sguardo, (a).
Il tema principale è piano, agitato e cresce a poco a poco
di intensità; è ansimante, parla di un fermento, di
un brivido interiore e si arresta su due accordi secchi, (b).
(a) Grave
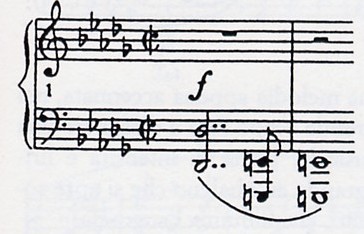
(b) Agitato
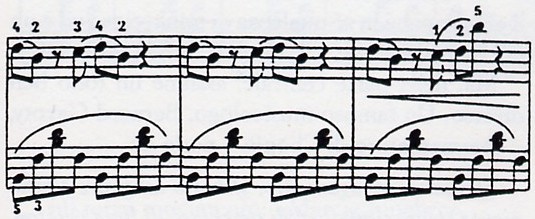
Cede, poi, spazio al secondo tema: alla gratificazione, alla
parola che rassicura, alla consolazione in questa angoscia.

All'inizio è una melodia appena accennata, ma a poco a
poco prende corpo fino a disegnare una grande frase musicale,
piena di intensità e lirismo... come un grande arcobaleno
che si apre sopra occhi sofferenti, che illumina l'angoscia.
Il secondo movimento ha caratteristiche simili al primo: ha in
sé qualcosa di minaccioso ed è un po'
ossessionante.
Ma, nella parte centrale, assume un tono ben diverso. Un famoso
musicologo, Bernard Gavoty, - commentatore di Chopin - parla
di:
«precario appagamento, sfibrato languore tipicamente
slavo, simbolico di un chiaro di luna velato».
Struggente nostalgia, parole dette in tono minore, con un
po' di riserbo; un desiderio di consolazione che penetra poco
alla volta.
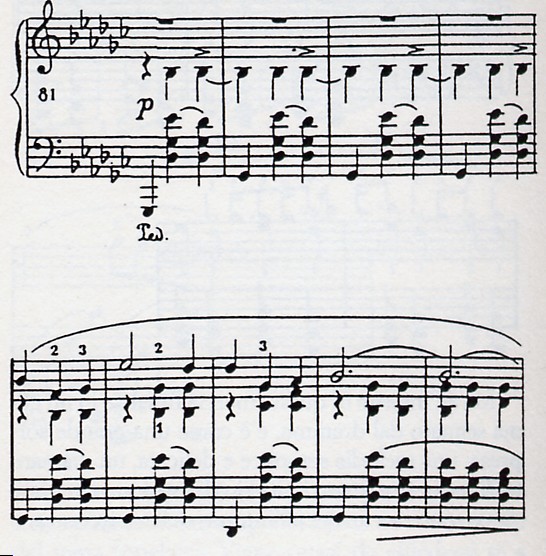
Il terzo movimento: «Marcia funebre».
E’ il punto nel quale le caratteristiche del brano vengono
poste fino all'estremo.
Da un lato infatti è l'eco stilizzata di tutti i dolori
umani.

Ma all'interno di questa marcia funebre in un clima segnato dal
dramma, c'è come una grande sorpresa: una melodia semplice
e delicata, un diamante di pace! Come un desiderio di respirare e
trovare vita e speranza anche all'interno della sofferenza.
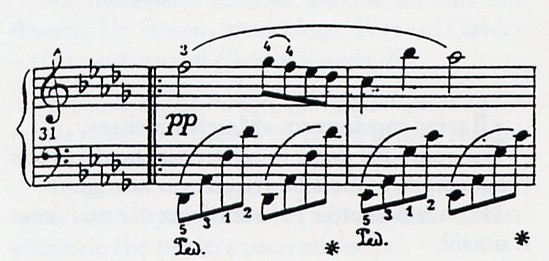

La cosa curiosa è che questa parte centrale è
straordinariamente ampia (48 battute contro le 60 del tema
funebre). Viene quasi da chiedersi se a Chopin stia più a
cuore dire il dolore o dire la speranza all'interno del dolore.
Non siamo certo autorizzati a parlare di presagio di
risurrezione, di lettura cristiana della morte: ci accontentiamo
di sentirne il profumo. Chopin, come sappiamo, non coltivò
la fede dell'infanzia che la madre gli aveva trasmessa. La
speranza di Chopin avrebbe avuto solo più tardi un nome e
un volto preciso: un suo caro amico prete, Aleksandr Jelowicki,
che in punto di morte lo confesserà.
Il quarto movimento è un brano molto innovativo e
straordinario. Le tonalità si succedono con un andamento
così allucinato e imprevedibile che non si può
parlare propriamente di tonalità. Come diceva Alfred
Cortot, il grande interprete di Chopin, assomiglia al
«turbine gelido del vento sulle tombe».
Ascolto musicale:
Fryderyk Chopin (1810-1849): Sonata n. 2 in si bemolle minore,
op. 35 «Marcia funebre»
- Grave - Doppio movimento;
- Scherzo - Più lento - Tempo I;
- Marche funèbre: Lento;
- Finale: Presto.
Nel mistero dei dolore: l'abbandono
C'è un elemento comune a questo essere
«oltre la soglia», a questo essere nel mistero del
dolore: il fatto che ciascuno si scopre solo. Sì, gli
altri esistono, ma sembra che siano incapaci di riempire il
vuoto.
Dentro questa realtà si fa strada una domanda: Dio
dov'è? Dov'è mentre io soffro? Ci ama così
tanto... ed è assente in un momento come questo? Che
risposta ha da dare al dolore dell'uomo?
Sono interrogativi penetranti per chi soffre e, soprattutto, se
ci mettiamo di fronte al dolore innocente; domande che emergono
in modo molto drammatico in un brano famoso di Elie Diesel, che
sembra offrire una risposta folgorante:
«Un bambino dal volto fine e bello,
incredibile in quel campo. Aveva il volto di un angelo infelice.
Le SS lo condannarono a morte assieme a due detenuti presso i
quali erano state scoperte altre armi.
Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche drizzate
sul piazzale dell'appello: tre corvi neri. Tre condannati
incatenati e fra loro il piccolo ragazzo, l'angelo dagli occhi
tristi.
Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete del
solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non
era un affare da poco. I tre condannati salirono insieme sulle
loro seggiole.
- Dov'è il buon Dio? Dov'è - domandò
qualcuno dietro me.
Ad un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte.
Dietro di me udii il solito uomo domandare:
- Dov'è dunque Dio?
E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:
Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca
... » 3.
Ecco dov'è Dio quando l'uomo soffre: è appeso
lì, ad una croce.
Dio non guarda il dolore dell'uomo da spettatore cinico e
disinteressato: Dio ha conosciuto fino in fondo cosa vuol dire
soffrire. Fermiamoci a fissare il nostro sguardo sulla croce e
guardiamo così al centro del Mistero: Dio che per amore si
spoglia di tutto e condivide così il dolore di ciascun
uomo. Gesù ha vissuto questi momenti terribili culminati
con la sensazione di abbandono:
«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio
su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran
voce: "Eli, Eli, lemà sabactàni?", che significa:
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo
questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elia". E
subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di
aceto, la fissò su una canna e così gli dava da
bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a
salvarlo! ". E Gesù, emesso un alto grido,
spirò» (Matteo 27,45-50).
Anche lui non ha sentito il Padre - cosa quasi impossibile da
dire -, ed è stato come «senza Dio» in quel
momento: è il crocifisso anche degli atei. Ha voluto
conoscere la sofferenza dell'uomo in tutte le sue sfumature,
abbracciandole tutte quante in sé, perché nessuno
possa più prendersela con Dio e dire: il mio dolore
è sconosciuto al cuore di Dio.
Quindi, ogni volta che soffriamo partecipiamo a quel dolore
abissale, immenso e incalcolabile che è quello provato dal
cuore del Figlio di Dio.
Cambia cosi il nostro modo di guardare a Dio: non è
assente, ma ci ha talmente amato da voler condividere anche
questo dolore; è il momento in cui ci ha amato di
più.
Il cammino è personale: è vostro, è mio,
è degli autori che ascoltiamo, è di Gesù
stesso. Camminiamo insieme: io con voi, noi con Gesù
attraverso la musica.
Il brano di Ravel che vi propongo, ha ininterrottamente sullo
sfondo un rintocco di campane: proviamo ad immaginare quelle del
Venerdì Santo.
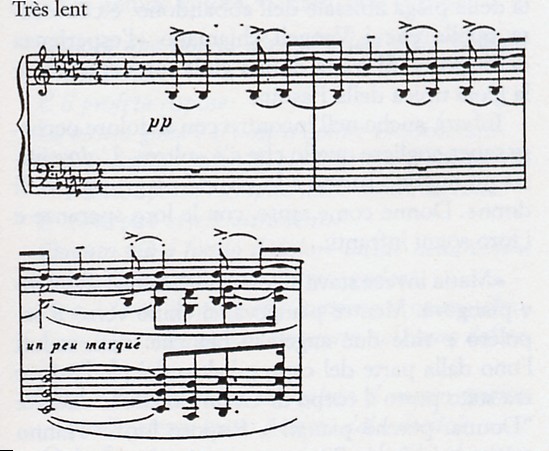
Da questi rintocchi emerge una melodia intensa e
sofferta, che sembra esprimere bene questa
piaga interiore dell'abbandono di Gesù e di tutta
l'umanità che si interroga di fronte al dolore.
Ascolto musicale:
Maurice Ravel (1875-1937): Le gibet (Il patibolo), da
«Gaspard de la nuit».
Pasqua è gioia
Non vogliamo fermarci, ma andare sempre
«oltre», per arrivare a cogliere ciò che
c'è anche al di là della piaga abissale
dell'abbandono, e conoscere quella che i Vangeli chiamano
«l'esperienza della gioia». Si tratta di una gioia
tutta speciale: è la gioia tipica della Pasqua.
Infatti, anche nell'incontro con il dolore occorre saper cogliere
quello che c'è «oltre». L'oltre inizia un
mattino presto e lo vivono un gruppetto di donne. Donne come
tante, con le loro speranze e i loro sogni infranti:
«Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e
vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del
capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di
Gesù. Ed essi le dissero: Donna perché piangi?".
Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo
hanno posto". Detto questo, si voltò indietro e vide
Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era
Gesù.
Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?".
Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:
"Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io
andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria! ". Essa
allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico:
"Rabbunì! ", che significa: Maestro! »
(Giovanni 20,11-16).
Ecco la gioia di Maria nel riconoscere Gesù. Una gioia che
non si sarebbe mai aspettata. Una gioia dentro il dolore e la
sofferenza.
Che cos'è questa gioia che nasce da una lacrima? Un grande
autore, Gibran, così. scrive:
«Allora una donna disse: Parlaci della
Gioia e del Dolore.
E il profeta rispose:
La vostra gioia è il vostro dolore smascherato.
E’ il medesimo pozzo da cui proviene il vostro riso:
è stato spesso riempito dalle vostre lacrime.
E come può essere altrimenti?
Quanto più a fondo il dolore incide nella vostra vita,
tanta più gioia potrete godere.
Non è forse il calice che contiene il vostro vino, quello
stesso calice temperato nel forno del vasaio?
Non è forse il liuto che calma il vostro spirito, quello
stesso legno scavato dal coltello?
Quando siete tristi, guardate in fondo al vostro cuore e capirete
che in realtà state piangendo per ciò che
già prima fu una vostra gioia.
In verità voi siete come bilance oscillanti fra il dolore
e la gioia.
Solo quando siete vuoti siete fermi e ben bilanciati.
Ma quando il tesoriere vi solleva per pesare il suo oro e il suo
argento, la vostra gioia ed il vostro dolore sono obbligati a
salire o a scendere» 4.
Quali sono le gioie che noi ricordiamo?
Certamente tutti abbiamo fatto esperienze di gioie, e anche di
quelle che ci rendono euforici e carichi di entusiasmo, ma che
poi non mantengono la loro promessa: svaniscono e lasciano
soltanto nostalgia, o anche tristezza.
Diversa è la gioia della Pasqua, perché ha alla
radice la croce e passa attraverso la croce; ha alla radice la
sofferenza e il dolore e passa attraverso la sofferenza e il
dolore. La vera gioia del cuore dell'uomo percorre questo
cammino. E’ la gioia vera che può dimorare
stabilmente nel cuore dell'uomo. E' quella gioia che nessuno ci
può portare via e che Gesù aveva promesso ai suoi
discepoli:
«Così, anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Questo vi ho
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena» (Giovanni 16,22-23; 15, 11).
Si fa l'esperienza delle lacrime di gioia, il piangere di gioia.
E' capitato anche a me, quando ho detto il mio
«sì» a Gesù.
Il brano musicale che vi propongo può in certo modo
esprimere la gioia pasquale; fa parte dei viaggi di Franz Liszt,
che racconta poi in musica ciò che ha visto, facendo
rivivere emozioni ed esperienze. Parla di campane, nasce sull'eco
di campane a festa, vogliamo immaginare, con un po' di fantasia,
quelle di Pasqua.
Inizia con un rintocco di campane - ben diverse da quelle di
prima:

Su questo rintocco nasce una melodia spontanea,
quasi improvvisata, che crea l'attesa di una gioia piena.
Questa parte introduttiva sfocia finalmente in un'ampia
melodia:
Cantabile con moto
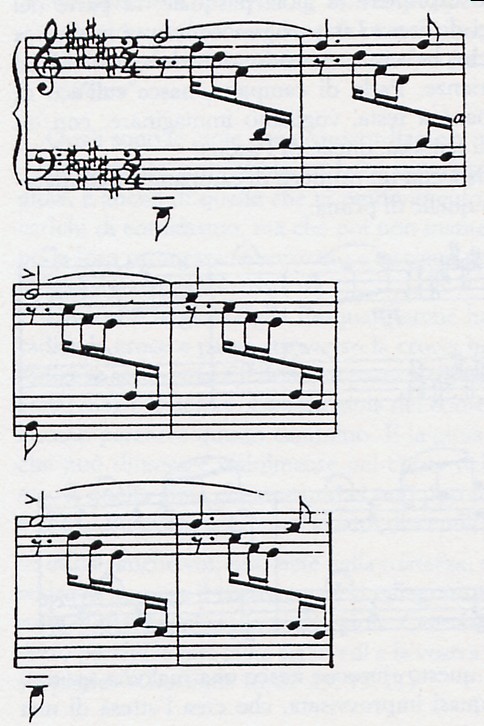
quasi un canto eterno che cresce d'intensità:
come avviene per la gioia della Pasqua, che entra sempre
più nel cuore, fino ad esplodere in un'esultanza
incontenibile. Raggiunto poi il punto culminante riappare presto
il rintocco delle campane iniziali... L'eco lontana dalla quale
tutto è nato e da cui la gioia ha preso forma.
Ascolto musicale:
Franz Liszt (1811-1886): Le campane di Ginevra (Notturno); da
«Anni di pellegrinaggio» - Primo anno: Svizzera.
Pasqua è vita
Andando «oltre» abbiamo quindi colto
questa mistero di gioia che è anche mistero di vita, la
vita invincibile, quella che ribalta la pietra del sepolcro,
quella che è più forte di ogni morte. Parlando
della Pasqua infatti, parliamo soprattutto di vita. L'esperienza
di Gesù è stata esperienza di vita; e non è
stata solo un'esperienza sua, ma può esser anche nostra.
Come accadde ad un'altra donna, la samaritana:
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma
chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai
più sete, anzi, l'acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la
vita eterna» (Giovanni 4, 13 -14).
Acqua viva che è nel cuore del credente, sorgente
d'acqua che zampilla; qualcosa di fresco e di nuovo che è
capace di trasformare ogni uomo.
Anch'io dopo aver detto quel «sì» tra le
lacrime ho trovato questa vita nella gioia di seguire
Gesù, pure in mezzo a tutte le fatiche in questo dire
«sì» ogni giorno all'amore di Dio.
E per noi? Esiste l'esperienza della vita? Possiamo dire che
c'è vita piena oggi per noi?
Ascoltiamo la testimonianza di un uomo, Antonio Savasta, che ha
visto cambiare la sua vita, perché qualcuno gli ha messo
nel cuore un seme di vita nuova, di una vita capace di amare e di
perdonare anche quando spira la violenza:
«Nei giorni del sequestro suo marito era
come lei lo descriveva: pacato, pieno di fede, incapace di
odiarci e con una dignità altissima. Lo so, signora,
questo non le restituirà molto, ma sappia che dentro di me
ha vinto la parola che portava suo marito.
L'ha vinta contro tutti coloro che ancora oggi non capiscono.
Anche in quei momenti suo marito ha dato amore, è stato un
seme così potente che neanche io che ci lottavo contro
sono riuscito a estinguere dentro di me. Questo è un fiore
che voglio coltivare per poter essere io a donarlo. Se non ci
foste stati voi, io sarei ancora perso nel deserto. Spero
soltanto di colmare questo vuoto restituendo e insegnando ad
altri quello che voi avete dato e insegnato a me» 5.
«Questo è un fiore che voglio coltivare per poter
essere io a donarlo»... E’ il seme della vita
nuova.
Franz Liszt, con un suo brano famoso, spero ci aiuterà a
comprendere meglio.
Tutta questa composizione è giocata sull'acqua. La sua
caratteristica preziosa è che la melodia continua a
scintillare, come riverberata da piccole onde.
La melodia è semplice, ma quest'acqua che gorgoglia,
scorre e vibra la rende bellissima.

E’ segno di vita nuova riempita da uno sguardo
diverso, da una luce diversa, come quella della Pasqua.
Ascolto musicale:
Franz Liszt: Les jeux d'eaux à la villa d'Este (I giochi
d'acqua alla villa d'Este); da «Anni di
pellegrinaggio» - Terzo anno.
Pasqua è danza
Come è possibile dire sempre di sì
perché sia sempre «gioia»? Come fare per
cercare e incontrare sempre il Risorto come Maria di Magdala?
Madeleine Delbrél parlandoci della vita cristiana ci
regala un'immagine splendida e dice che la vita è come una
danza, «Il ballo dell'obbedienza»:
«Se noi fossimo contenti di te, Signore,
Non potremmo resistere
A questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo,
E indovineremmo facilmente
Quale danza ti piace farci danzare
Facendo i passi che la tua Provvidenza ha segnato.
Lascia che noi inventiamo qualcosa
Per essere gente allegra che danza la propria vita con te.
Per essere un buon danzatore,
con te come con tutti,
non occorre sapere dove la danza conduce.
Basta seguire,
Essere gioioso,
Essere leggero,
E soprattutto non essere rigido,
Non occorre chiederti spiegazioni
Sui passi che ti piace segnare.
Bisogna essere come un prolungamento,
Vivo e agile, di te.
Ma noi dimentichiamo la musica del tuo Spirito,
E facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica:
Dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza,
Che la tua Santa Volontà
E’ di un'inconcepibile fantasia,
E che non c'è monotonia e noia
Se non per le anime vecchie,
Tappezzeria
Nel ballo di gioia che è il tuo amore.
Signore, vieni ad invitarci.
Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo
Che sono tristi:
Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo
Che sono logoranti.
E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo:
Anche questo è danza.
Signore, insegnaci il posto
che tiene, nel romanzo eterno
avviato fra te e noi,
il ballo della nostra obbedienza.
Facci vivere la nostra vita
Come un ballo,
Come una danza,
Fra le braccia della tua grazia,
Nella musica che riempie l'universo d'amore.
Signore, vieni ad invitarci» 6.
Anche per me è stato così. Quando sono
entrato in seminario pensavo che avrei dovuto lasciare per sempre
alle spalle il pianoforte. Poi l'Arcivescovo mi ha chiesto di
«fare il prete con il
pianoforte». Danzare per me è stato anche
seguire quest'indicazione ed oggi la vita, per me, è
questa danza: una danza che nasce dall'incontro con un dolore
abbracciato, con un amore trovato; una danza che si trova
«oltre la soglia» nel mistero dell'amore: una danza
piena.
Tutto questo è bene espresso da un brano di Chopin: una
danza vigorosa e precisa; ma non rigida, morbida e flessuosa. E
un brano pieno di brio e di gioia... come quella della
Pasqua.
Ascolto musicale:
Fryderyk Chopin: Polacca in la bemolle maggiore op. 53
(«Eroica»).
Conclusione
«Oltre la soglia... il mistero»...
Abbiamo incontrato quella soglia; visto il volto che questa
soglia ha per ciascuno di noi; siamo andati «oltre»
per cogliere il mistero di vita, di gioia e di danza; per
cogliere il mistero dell'amore di Dio che solo può
riempire il nostro cuore, ben sapendo che quando si entra nel
Mistero possiamo cogliere certe cose, ma la maggior parte di esse
rimane ancora da scoprire.
Mi piacerebbe, a questo punto, invitare idealmente sul
palcoscenico una donna che ha conosciuto più di chiunque
altro il Mistero e questo abitare il Mistero del dolore e della
gioia; una donna che ha fatto di questo Mistero il senso della
sua vita, in modo pieno e straordinario: è Maria, la madre
di Gesù.
Lei ha gioito, vissuto e danzato nell'incontro con il
Mistero.
Concludiamo, allora, con l'Ave Maria di Schubert, preceduta da
una preghiera scritta da un grande Vescovo e grande poeta: Tonino
Bello.
«Santa Maria, donna che ben conosci la
danza,
ma anche donna che ben conosce il patire,
aiutaci a capire che il dolore non è l'ultima spiaggia
dell'uomo.
Non osiamo chiederti
né il dono dell'anestesia
né l'esenzione dalle tasse dell'amarezza.
Ti preghiamo solo che
nel momento della prova,
ci preservi dal pianto dei disperati.
Santa Maria, donna che ben conosci la danza,
facci capire che
la festa è l'ultima vocazione dell'uomo.
Accresci, pertanto, le nostre riserve di coraggio.
Raddoppia le nostre provviste di amore.
Alimentaci le lampade della speranza.
E fa che nelle frequenti carestie di felicità
che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere
con fede colui
che verrà finalmente a
«mutare il lamento in danza
e la veste di sacco in abito di gioia»
(Salmo 30,12)7.
Ascolto musicale:
Franz Schubert (1797-1828) - Franz Liszt: Ave Maria.
NOTE:
1 RAINER MARIA RILKE, IX
Elegia duinese, Einaudi, Torino 1978, pp. 56-57.
2CARLO MARIA MARTINI,
Ripartiamo da Dio, Centro Ambrosiano 1995, n. 5.
3ELIE WIESEL, La
notte, La Giuntina, Firenze 1980, pp. 65-67 passim
4KAMIL GIBRAN, Il Profeta,
Bompiani, Milano 1990, pp. 41-43 passim.
5ANTONIO SAVASTA,
(ex-brigatista), Testimonianza che scrisse alla moglie di Pino
Taliercio, assassinato nel 1981.
6MADELEINE DELBREL, Noi
delle strade, Gribaudi, Torino, pp. 86-89 passim
7TONINO BELLO, Maria
donna dei nostri giorni, Paoline, Cinisello Balsamo 1993, pp.
88-89 passim.
RISONANZE SU UN ASCOLTATORE
Non capisco molto di musica, ma quanto mi piace
ascoltarla e con quei suoni belli quanto incomprensibili
dialogare stando sulla soglia tra rivelato e suggerito.
La musica è linguaggio; è messaggio solo suggerito
non perché non compreso fino in fondo, ma proprio
perché compreso a un livello non raggiungibile
razionalmente e per questo restituito nel codice intuitivo delle
note musicali. La musica è un messaggio che continua ad
essere tramandato pur restando inespresso in termini logici;
è il passaggio sottocutaneo dell'intelletto.
Sono andato ad ascoltare (non a sentire) il concert di don Carlo
cercando di essere come una brocca vuota e mentre la musica mi si
versava dentro, la brocca - che ero io in quel momento- ha dato
la sua forma al nuovo contenuto dando vita al messaggio intuitivo
e detto sottovoce, che ho subito trascritto in tempo reale. Se
conoscessi la grammatica della musica ne sarebbe nata una melodia
nuova; ma così non è e ho dovuto fissare
l'intuizione in un altro linguaggio: quello più incerto e
zoppicante della poesia.
Questo è il sedimento poetico - anch'esso intuitivo e solo
suggerito - del messaggio musicale; la coagulazione del fluire
movimentato delle note misteriose in secche parole quotidiane, ma
- di nuovo - il messaggio vuole essere lo stesso.
Come avvolti
dalle spirali di profumi
sovrapposti
come ricordi
evocati
come il rincorrersi
affannoso
della memoria
che vede terra
infine
-una delle terre possibili -
come una morte cantata
un diamante di dolore cristallizzato dagli sconvolgimenti della
terra
pace di pianura
ma poi si è vivi
e presi
nella tempesta
i gorghi congelati dell'animo
sulla soglia del dolore
la tempesta del mistero
«uomini di poca fede
di cosa avete paura
si calmano i venti,
si calmano le acque
si calmino in voi.
Io sono la resurrezione
e l'amore»
la gioia è ciclico annuncio
sempre nuova luce irrompe
sulla soglia quotidiana del dolore
come in un fiume
l'acqua
che è
sempre lo stesso fiume
e va col suo dolore
dove non sa
come una danza.
Giovanni Gabardini
![]()